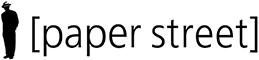La donna dello scrittore
Christian Petzold torna a misurarsi con la Storia, tracciando uno spazio eterotopico, di transito
Emigrare, scrive Chen He, scrittore contemporaneo di Wenzhou trasferitosi in Albania e poi in Canada, significa imboccare un lungo cammino costellato di sogni realizzati e sogni spezzati allo stesso tempo. Georg è un rifugiato tedesco nella Francia occupata dai nazifascisti. Sfuggendo ai rastrellamenti e preso possesso dell’identità di uno scrittore suicida, riesce ad arrivare a Marsiglia, uno spazio differente, un luogo altro in cui nessuno gli presta attenzione, in cui il migrante non viene visto ed è come un fantasma. Non esiste. Marsiglia è così un’area di transito dove il silenzio è formicolante e minaccioso e la storia è come se incedesse in un moto perenne, ripetendosi, riecheggiando quasi meccanicamente, questa volta anche visibilmente sotto la nostra pelle.

Dopo un film in cui memoria storica e melodramma identitario s’intrecciano in un racconto dalla lucidità e forza spiazzanti Il segreto del suo volto (2014), Christian Petzold torna a misurarsi con quella stessa Storia, riadattandone sfacciatamente spettri e immagini alla Francia di oggi. Infatti «il cinema ama i fantasmi, così come tutti gli esseri perduti» sostiene il regista, e La donna dello scrittore ne è pieno, pieno di quelle allucinazioni con cui, paradossalmente, è possibile dar vita a un preciso realismo di contorni e forme ben poggiate sul suolo – la città – e intorno come un’atmosfera di “magia” che faccia sentire le illimitate possibilità che il cinema ha, di coesione di trame, tempi e spazi.

Impianto temporale stratificato e intreccio multiforme e coerente sono gli elementi più lampanti e complessi del film di Petzold, riconducibili a un’idea di rappresentazione e a un modo di trattare la materia ben chiari. C’è la padronanza di determinate scelte formali, anch’essa dettata da una coscienza storica, il noir e il giallo con i cui meccanismi il racconto incalza regolare e senza sbavature, e c’è ancora una volta il melodramma, il genere della distanza incolmabile, dello scarto, e che in Petzold vive di suggestioni, primissimi piani e parole taciute. Dietro la messinscena perfetta, Marsiglia è il luogo eterotopico per eccellenza: Foucault sosteneva che le eterotopie fossero luoghi abitati da phantasma e in cui trovano spazio territori ontologicamente ibridi e sospesi tra reale e immaginario, posti reali in cui si giustappongono differenti spazi (o tempi, nel nostro caso) che di solito sarebbero incompatibili. La tragicità della storia passata e la condizione liminare di atavico passaggio e mai di permanenza di chi l’ha vissuta si riverberano in un presente che non è mai stato così vicino a ciò che è stato, costruendo, il cineasta tedesco, nient’altro che contrazioni e miniature di un male che vive e prende forma endemicamente, rispetto al ripetersi ciclico e sordo della storia dell’uomo. In questo senso, eterotopie sono zone vuote che la società e il potere relegano i margini, luoghi senza memoria, senza presente né passato, limbi di attese, ricerche e speranze che quasi mai si realizzano, dove si transita – il vagare, sconnesso, di Georg – senza mai sapere realmente dove ci si dirige.