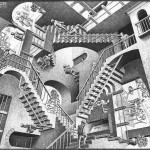Oltre la provincialità del ‘villaggio’ Roma
Short Theatre XI si rinnova
Io ringraziare desidero
per tutti quelli che sono piccoli liberi e limpidi
per le facce del mondo che sono varie
per quando la notte si dorme abbracciati
per quando siamo attenti e innamorati, fragili e confusi,
cercatori indecisi.
Non possiamo che cominciare dalla fine per raccontare questa XI edizione di Short Theatre, dalle parole preziose di Mariangela Gualtieri: poetessa rara, anima sensibile, sarta di grazia, che domenica scorsa ha dato la quadratura del cerchio a un festival che, al di là dell’esito dei singoli spettacoli (di cui tracceremo alcune traiettorie), è sicuramente riuscito a operare quel “rammendo” – per dirla con le parole di Renzo Piano – di cui questo tempo ha bisogno.
A Cesare quel che è di Cesare: ricominciare dalla riconoscenza
La situazione romana è certamente complessa e non staremo qui a elencare tutte le perplessità che suscita l’avvenire teatrale capitolino, però è giusto e necessario che venga riconosciuto il valore alle azioni. Fabrizio Acuri e Francesca Corona sono riusciti a persguire ciò che si proponevano cioè “Keep the village alive”, nella duplice lettura che quel titolo porta con sé: mantenere viva la comunità, sì, ma al contempo coniugare lo slancio all’internazionalità (uno dei rari casi in cui il ricorso all’inglese ha la sua ragione d’essere, cioè rivolgersi a un pubblico non strettamente romano-italiano) con la sprovincializzazione del “villaggio”.
Ed è indubbio che la ventata più fresca sia arrivata innanzitutto dagli spettacoli stranieri. Non tanto per la tipica sindrome italiana da esterofilia, quanto piuttosto perché sono stati selezionati spettacoli molto diversi tra di loro e molto diversi da ciò che – anche nel teatro di ricerca nostrano – siamo abituati a vedere.
La lezione straniera: l’ibridazione dei linguaggi
È il caso in primis dello svizzero Milo Rau che con i suoi Five easy pieces porta in scena un’acuta riflessione sul teatro attraverso modalità proprie, innanzitutto, al cinema e alla televisione.
In alto è un grande schermo su cui viene proiettato ciò che la macchina da presa riprende dal vivo: lì, là dentro, è il prodotto finale, ma davanti agli occhi del pubblico intanto c’è il set aperto che mostra la costruzione della finzione.
Se osserviamo ciò che accade in scena siamo portati spesso a sorridere (l’ironia), ma concentrandoci sullo schermo invece tendiamo alla commozione (il dramma). Cosa preferiamo guardare allora? Si dice che il teatro debba emozionare, ma quali emozioni stiamo chiedendo al mercato? Siamo consapevoli del nostro peso nell’economia mondiale? (per riscoprire lo spettacolo rinviamo all’attenta lettura di Sergio Lo Gatto).
Non possiamo poi non citare i catalani El Conde de Torrefiel che, dopo le produzioni degli scorsi anni (qui a Short 9, qui a Terni 10) molto più spudoratamente provocatorie, ritornano in Italia con uno spettacolo estremamente più omogeneo. Il loro è un teatro tipicamente postmoderno nonché post-drammatico, in cui, anche in questo caso, l’azione è volontariamente portata alla schizofrenia: in alto, lunghe stringhe di didascalie (recitate da una voce fuori campo); sul palco, quattro performer. Le une sviluppano una riflessione – attraverso citazioni o narrazioni ruotanti attorno artisti e pensatori contemporanei – sulla società e sulla cultura del presente; gli altri silenziosamente dànno vita al Reale (da non confondere con la Realtà), detonando l’esilarante scarto fra il desiderio di divenire e l’inerzia del permanere (espediente analogo in Edges della croata Ivana Müller che in questo caso, però, si avvita in voci fuori campo molto più fragili e inconsistenti).
Freschissimo poi l’approccio dei belgi tg STAN nel portare in scena Pinter (ne abbiamo parlato qui), approccio che andrebbe tesaurizzato in Italia: non tanto per la ricerca (che, qui, si assesta su stilemi drammatici non particolarmente innovativi), quanto per la recitazione e la spigliata messa in scena, che supera l’obsolescenza delle accademie e le enfasi filodrammatiche simil Muccino nostrane sempre più ricorrenti nelle produzioni degli stabili (e non solo).
Fatichiamo, invece, a condividere l’entusiasmo di Porcheddu (leggi qui) per il saggio dell’Ecoles des Maîtres diretto dalla brasiliana Christiane Jatahy che, al contrario dello scorso anno (una complessa ma affascinante conferenza spettacolo – il maestro era Ivica Buljan – sul Capitale di Piketty, testo fondamentale del nostro tempo), ha presentato un progetto farraginoso, in cui l’improvvisazione su canovaccio attorno a temi di attualità ha rivelato le falle di un gruppo poco affiatato, spesso preda dell’impasse creativa, tanto che infine l’intera operazione ci è parsa una prova poco riuscita di esercizi scolastici.
Di segno completamente opposto la magmatica invenzione del portoghese Tiago Rodrigues che ci porta a un’altra importante traiettoria tracciata da Short Theatre.
Spettacolo interattivo vs. Pubblico interagente: teatro e spettatore a contatto
Nella sperimentazione di nuove forme di spettacolo, c’è sicuramente la ricerca di forme altre di fruizione.
Sono, ad esempio, le fiabe di Licia Lanera recitate a fil di guanciale tra i letti della Pelanda: dolce, amorevole, suadente la voce, ma questa “mamma” della buonanotte rinfocola in realtà il lato perturbante della letteratura folkloristica, tenendo svegli, lucidissimi, gli spettatori, come dovrebbe ricominciare a fare l’arte anziché addormentare tutti in un intrattenimento esibizionistico (e in questo l’attrice pugliese, fuori dagli eccessi delle Fibre, valorizza finalmente il suo notevole talento).
Curioso, divertente, autoironico, ma forse un po’ troppo sgangherato, il viaggio partecipato nelle riflessioni di un morto – Tamam Shud – di Alex Cecchetti: percorso nervoso tra le quinte del Teatro India, dove ci ritroviamo ora fermi, ora in movimento, costantemente scherniti, spostati, azzittiti dall’artista che è tutto immerso nel suo vano processo di rievocazione. A ricordarne l’ormai compiuto fato, due cantanti lirici: vólto di foglie d’oro alla maniera di Beuys, generi invertiti (lei voce bassa, lui acuta), sono le guide ultraterrene in questo regno del possibile.
Godibilissimo nella sua ponderata leggerezza. Peccato che manchi un po’ di sostanza.
Sorprendente, infine, By Heart di Rodrigues (direttore del Teatro Nazionale “D. Maria II” di Lisbona – classe ’77), in cui il coinvolgimento – moderato – del pubblico diventa un elemento drammaturgico fondamentale. L’atto dell’imparare a memoria (“by heart”) – cioè di diventare memoria vivente ed ereditabile – intreccia sul palco innumerevoli vicende, private, letterarie e storiche, infondendo a questa semi-improvvisata genuina operazione un respiro talmente profondo da superare il teatro sublimandolo a atto partecipato e responsabile di presenza attiva collettiva.
Breve parentesi drammat(urg)ica: la penna stanca del contemporaneo
Per completezza dovremmo aggiungere che Short Theatre non ha mancato di indagare la drammaturgia contemporanea (della danza abbiamo, in parte, già parlato qui), ma indipendentemente dagli esiti (eccezion fatta per Carnevali e Salzmann) ci è parso che le nuove scritture presentate fossero molto deboli o già consumate – in anticipo sul futuro – dall’usura del tempo: troppo poco immaginifiche, ovvero talmente legate al dato reale da seguirlo pedissequamente senza particolari slanci prospettici. Manca un po’ di briosa fantasia. Forse l’effetto di sessant’anni di consumismo è che pian piano anche l’immaginazione si è piegata a un materialismo nichilista, tanto che sarcasmo e scetticismo oggigiorno sembrano essere diventati sinonimi di brillante intelligenza – anziché di paura.
Un rinnovamento salutare all’insegna della curiosità
Io ringraziare desidero. Eravamo partiti da qui. Ed effettivamente quest’anno va riconosciuto a Short Theatre il grande merito di essere riuscito a rinnovarsi, superando le fragilità della scorsa edizione e l’autoreferenzialità sempre più evidente dei festival nazionali, attraverso una proposta valida ma soprattutto stimolante per gli artisti, gli operatori e gli spettatori, cioè la cosiddetta comunità. A dimostrazione del fatto che un festival può smarcarsi dall'”effetto vetrina” (di quegli stessi spettacoli che tanto comunque gireranno, soprattutto in un polo come Roma) e inserirsi attivamente nella proposta culturale – quindi anche politica (perché “il villaggio” cresce in relazione agli stimoli che riceve) – di una città.
Perché ciò accada, come hanno dimostrato Arcuri e Corona, è necessario che chi lo dirige sappia mantenere viva la curiosità di scoprire (il cosiddetto scouting), perché questa – inevitabilmente – si rifletterà nel pubblico.
Foto:
©Carolina Farina
©Claudia Pajewski
Crediti:
direzione artistica Fabrizio Arcuri
direzione generale e cura dei progetti internazionali Francesca Corona
organizzazione e produzione Matteo Angius, Monica Maffei, Giulia Messia
in collaborazion con Marco De Francesca
direzione amministrativa Roberta Scaglione con Elena Campanile
in collaborazione con Marica Mandiroli
direzione tecnica Diego Labonia, Chiara Martinelli
in collaborazione con Mattia Santilli
comunicazione Laura Marano
in collaborazione con Lorenza Accardo, Livia Filippi, Alessia Musca, Valerio Telesca
ufficio stampa Amelia Realino
con la collaborazione di Laura Marano
redazione testi catalogo Matteo Angius
accoglienza operatori Valentina Pastore
graphic art direction Simone TSO
foto Claudia Pajewski
video e-performance
web master Danilo Domenichetti