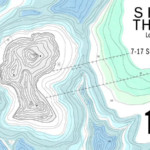Battlefield o la dimensione condivisa dell’ascolto
Peter Brook ritorna al Mahabharata
Capita spesso che sia la scena finale di un libro, di un film, di uno spettacolo a imprimersi nella mente e divenire il bandolo da cui dipanare e ricollegare il senso e le impressioni di un’esperienza, sia essa di lettura, di visione, di condivisione. Nel caso di Battlefield, il bandolo riconduce a una fisionomia, anzi a quattro: quelle degli attori (Carole Karemera, Jared McNeill,Ery Nzaramba e Sean O’Callaghan)che, fuori dal proprio ruolo, seduti a terra, rivolgono lo sguardo verso una fonte non semplicemente sonora, in atteggiamento d’ascolto. È In quell’immagine che ci riflettiamo, non come pubblico ma come esseri appartenenti a un destino comune.
A distanza di trent’anni Peter Book e Marie-Hélène Estienne tornano nuovamente a coniugare la dimensione rituale del teatro con la tensione epica del Mahabharata, ilfamoso poema indiano, la cui attualità, ancora una volta, si fa urgenza per una riflessione condivisa sul nostro contemporaneo.
Come bambini, adunati attorno ai cantastorie, apprendiamo le vicende di un’epopea che sembra nascondere, nelle sue contraddizioni, le inquietudini dell’agire umano, quell’eterna lotta di forze avverse, in cui i concetti di Bene e Male si fanno ingannevoli, non pretendono di essere Assoluti ma, anzi, si frantumano di fronte all’umanità dei suoi personaggi: nel racconto della guerra fratricida della famiglia Bharata, la vittoria ha il sapore amaro della sconfitta; il dolore della perdita, quello del rimorso per un massacro che poteva essere evitato.
Filtrando l’opera nell’essenzialità di settanta minuti a fronte della durata originaria di nove ore Brook presenta sul palco, coerentemente con la sua esperienza, la semplicità di uno spazio vuoto (luci Philippe Vialatte). Gli attori sono i rapsodi che lo abitano, che con ironia ci conducono per mano attraverso storie lontane eppur mai così attuali, in qualità di portavoce di uomini, divinità, sovrani, aquile o serpenti. Pochi funzionali oggetti per operare la trasformazione, laddove la parola decida di farsi azione (costumi Oria Puppo). Sì, perché coerentemente con le originarie modalità di trasmissione dell’opera, ciò che prevale è proprio la dimensione dell’ascolto.
E se la parola è il veicolo razionale di ciò che, almeno nelle intenzioni, vuole essere un processo di conoscenza e consapevolezza, il suono è il suo contrappunto atavico. Lo suggerisce in fondo la presenza costante sulla scena del musicista Toshi Tsuchitori, di quelle percussioni che, tra silenzi e ritmi incalzanti, racchiudono sinesteticamente la ricchezza della natura onnicomprensiva del Mahabharata e quindi del nostro mondo. Quel suono è il racconto di cui gli attori sono infine in ascolto. Un racconto che vuole aprire gli occhi sul nostro passato, guardando al nostro presente.
Se il ricorso quasi esclusivo alla forma orale minî in parte all’efficacia comunicativa dell’opera, costituendo un limite stretto alla sua potenzialità visiva, Brook non sembra preoccuparsene: epurando il tutto da ogni tipo di superficialità, il regista stimola al recupero di un maggior grado di attenzione, ricostruisce uno spazio di condivisione, non ridotto al solo esserci, qui e ora ma ampliato nel riconoscimento consapevole di una realtà atemporale, sempre comune, di fronte ai cui disequilibri l’uomo è ancora una volta chiamato a interrogarsi.
(Foto ©Caroline Moreau | Simone Annand)
Ascolto consigliato
Teatro Argentina, Roma – 12 maggio 2016