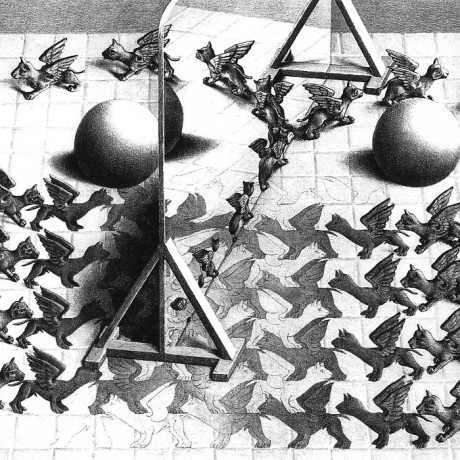24 ore nel Mount Olympus di Jan Fabre
La vita senza interruzioni
Un capolavoro? L’evento dell’anno? Oppure la “vacuità” di uno “pseudo artista”? Da quando è scoccata la venticinquesima ora di Mount Olympus, le reazioni non si sono fatte attendere: è innegabile, Jan Fabre ha innescato un curioso isterismo collettivo, che il precario mondo teatrale italiano ha subito salutato con entusiasmo, tanto più che per una volta è riuscito a rimbalzare anche oltre la comunità di appassionati. Ma in fondo questo Mount Olympus cos’era? E soprattutto—com’era?

Foto di scena ©Phil Griffin
Per rispondere bisogna innanzitutto prendere le distanze, perché MO gioca sulle emozioni (vedremo bene quali), e lo fa già a partire da ciò che lo ha reso un appuntamento imperdibile: la sua anomala straordinarietà. Dedicarsi totalmente a un’unica attività oggigiorno è diventata cosa rara, figurarsi poi trascorrere ventiquattr’ore in un teatro. Ma varrà la pena sfatare subito il primo mito: come “evento” queste ore doveva sicuramente durarle tutte e ventiquattro; come “spettacolo” decisamente no. MO però non è uno spettacolo (se lo è, non è certo un capolavoro), e forse non è neanche un evento. A pensarci bene infatti MO non avviene—è.
Ecco, partiamo da qui. Per capire l’operazione di Fabre bisogna dimenticare tutto: dimenticare Fabre, la tragedia greca, RomaEuropa, l’Argentina, le ventiquattro ore, il teatro—fare tabula rasa e ripartire da un dato. MO è un tempo.
• Il tempo senza durata
Pensare a MO come qualcosa che inizia e finisce è fuorviante. Chiunque abbia vissuto tutte e ventiquattro le ore in teatro (pur dormendo, o uscendo di tanto in tanto, ma senza mai abbandonarlo davvero) potrà testimoniare che MO è sempre lì, presente: perfino durante le tre pause con gli attori sdraiati sul palcoscenico nei sacchi a pelo, non dà mai l’impressione che si interrompa, non concede cioè mai l’illusione (o la disillusione) che sia tutta una finzione: qualunque cosa accada in scena non lascia mai immaginare un altrove “più reale”. Insomma, il primo dato è che Fabre non evoca ma fa esistere un mondo altro, indipendente e parallelo. Nessuno si deve sentire costretto ad assistere, le cose vi accadranno comunque.
C’è un altro motivo, poi, per cui il concetto di durata non sussiste: l’intero lavoro si sviluppa attorno al concetto di ciclicità; non solo si apre e si chiude, bene o male, alla stessa maniera, ma la prima immagine che ci viene rivelata già dice tutto da sé: «Il serpente si srotola». Eccolo, è l’Uroboro che smette di mordersi la coda per un attimo (di fatto a pronunciarlo saranno bocche che soffiano dall’ano per prendere voce da altre labbra) e ci lascia entrare nel suo cerchio. Divorati in questo tempo, diventiamo parte del tutto.
Foto di scena ©Wonge Bergman
• La ciclicità del tempo
In MO la circolarità è fondamentale. Storie, parole, scene, danze, oggetti si ripetono in continuazione con varianti. Ma non si tratta di quell’espediente di reiterazione per cui all’ennesima ripetizione finalmente giungerà il senso nascosto. Qui piuttosto l’accumulazione caleidoscopica induce familiarità e la familiarità genera simbiosi; per cui più passano le ore più il tempo si dilata, e la percezione, o meglio, l’aspettativa di durata scompare.
Ma proviamo a entrare nel dettaglio. Se MO tocca una ventina di tragedie e dunque di eroi greci, il loro “spazio” sarà incorniciato tra due tempi altri, che sono la danza e il sogno.
La danza segna sempre un passaggio, un rituale che non ha una durata in sé ma che in qualche modo riassume, condensandolo e rarefacendolo, lo scorrere di azioni metaforicamente quotidiane (in primis, la guerra). La danza è qualcosa che amplifica le azioni appena compiute, le spande, le fa vorticare e poi come una sliding door ci porta a un’altra azione: poco importa se accaduta prima, dopo, durante o altrove.
Foto di scena ©Wonge Bergman
Il sogno, invece, è il rigonfiamento irrisolto del pensiero, del sentimento, delle pulsioni sospese. Nel sonno il potenziale tragico delle vicende degli eroi esplode in presagio con tutto il dolore, il sangue o lo sconcerto che può implicare. Il sogno però, al tempo stesso, è il luogo dell’emancipazione da attuare nella veglia – «Ricordare un sogno è un atto di creazione» – pericoloso e attraente perché rivela la verità e trae in inganno. Non mancheranno infatti gli insonni, creature che rifiutando il sonno tentano la loro rivolta al fato.
Foto di scena ©Wonge Bergman
• Il tempo del fato
Arriviamo così a uno dei temi fondamentali, che è proprio il rapporto tipicamente greco dell’uomo con gli dèi, cioè dello scontro tra hybris e fato. Da questo punto di vista, MO è molto netto: nelle prime dodici ore tale lotta ha una valenza metaforica “extra-greca” ben connotata; nelle seconde dodici si tende alla regressione. Cerchiamo di ripercorrerne speditamente le tappe.
Jan Fabre e Jeroen Olyslaegers attraverso le tragedie greche ci accompagnano alla riscoperta di una società, la nostra, che da collettiva si fa individualista e poi alienata, con graduale cambiamento di atteggiamento nei confronti degli dèi. Come ci ricorda Dioniso fin da principio, si tratterà infatti di «un processo di apprendimento».
Foto di scena ©Wonge Bergman
Si comincia con lo spettro di Dario (e gli spettri saranno i protagonisti principali di questo tempo espanso): «Non dimenticate che lo abbiamo fatto [scorrere il sangue] nel nome di tutti». Siamo nell’era della guerra, dei popoli che si combattono, l’individuo non esiste, domina la legge marziale.
Poi Eteocle che con i suoi si lancia in un estenuante salto della catena (la catena sarà sempre sinonimo di fato): «Il talento inespresso è il demone che divora il giorno».
Ritorno da poi con Ulisse che demolisce ogni imprecazione e accusa di Ecuba appellandosi alla legge «sangue chiama sangue».
Il primo cambiamento lo avvertiamo con Creonte, che solleva la sua debole protesta individuale: «È meglio regnare senza portare la corona».
Ecco allora la volta della hybris per eccellenza, quella di un Edipo cieco, fino a giungere all’affermazione più moderna dell’individualismo con una – toccante – performance di nudi speculari che evocano la figura di Narciso: l’uomo ha scoperto sé stesso.
Matura così l’arroganza dell’opposizione agli dèi, fra richiami prometeici ed echi estremamente contemporanei, quasi neoliberisti: «Il fuoco può essere rubato, la conoscenza può essere comprata».
E le figure femminili che appaiono sempre più marcate, forti, indipendenti (Fedra: «Tutto si esaurisce nelle nostre parole, eccolo il nostro presente»; o Alcesti con il proprio sacrificio), mentre gli uomini si fanno molli, più speculativi e vanitosi; fino ad avvicinarci ai corruttori della società costituita, come gli infanticidi Ercole (con una mano nera infilata nell’ano: agire contro natura) o Medea, grande protagonista, già evocata dalle note della Norma belliniana.
Infine si accenderà in un laboratorio di droghe sintetiche che suggerisce un’emancipazione dai piaceri concessi dalla natura (perciò da Dioniso) per una sorta di indipendentizzazione edonistica.
Foto di scena ©Wonge Bergman
Le seguenti dodici ore, invece, sembreranno procedere a ritroso: di fatto, l’invocazione delle Erinni da parte dello spettro di Clitennestra (che inaugura il ciclo degli Atridi) – per quanto le Furie dormienti siano gli attori e Oreste siamo noi posteri –, fa scattare una molla che riavvolge la spirale a ritroso fino a riportarci all’inizio, con un continuo ricorrere di formule, costruzioni, situazioni viste nella prima metà (e sarà proprio questo a negare costantemente la spettacolarità e a confermare la temporalità del lavoro).
Foto di scena ©Wonge Bergman
È interessante notare come a dominare sia sempre la voce sorniona di Dioniso, che prima scatena il furore, poi la follia, infine infonde la consapevolezza – superando il trito concetto di edonismo (metafora da applicare all’arte stessa) – attraverso un processo di freno repentino dell’orgasmo vitale; per cui – secondo lo stesso principio di ciclicità – non è più l’appagamento a segnare il piacere ma la tensione vibrante al desiderio. Coronato dalla frase: «Gli dei che amate sono una vostra idea e una vostra proiezione del vostro desiderio di castigo».
Foto di scena ©Wonge Bergman
• Il tempo liberato
Giungiamo così al vertice di MO, toccando finalmente l’elemento più plateale e forte dell’intero lavoro: il sangue. Se è vero che nella tragedia greca la morte non doveva mai avere luogo in scena ma essere soltanto raccontata, Fabre rispetta l’assioma; ciononostante l’evocazione non lascerà nulla all’immaginazione.
Dall’inizio alla fine, interiora di animali saranno lanciate, sbattute, azzannate, lavate, accumulate, spandendo umori sanguigni dal pungente odore dolciastro per tutto il palco. Già, perché la tragedia non è solo una “farsa inventata” bensì una frazione iconica di una realtà molto più vasta: e per quanto esasperatamente reiterato (come tutto il resto d’altronde), questo impiego quasi nitschano del sangue suggerisce un’idea di cosa sia un massacro, centinaia, migliaia di corpi sacrificati. Il valore e il peso del sangue. Il prezzo della morte e della vita.
C’è, però, un altro dato estremamente importante. Dalle 19:00 di sabato alle 19:00 di domenica, il palco non sarà mai lavato o spazzato. Il sangue si secca, si attacca alle palme dei piedi, si impasta con la terra, il sudore, le vesti, perché ognuno lo porti via con sé, finché un nuovo spargimento inonderà di nuovo il palco di carne.
Proprio come quei mostri che, nascendo dalla stratificazione di mani e mani di trucco, ci mostrano che sotto un basilisco, una gorgone o un’arpia c’è solo un uomo che non è più riuscito a lavarsi delle sue colpe, allo stesso modo la vera lezione di MO sembra essere che la storia si ripete, ma gli uomini non imparano. Creano nuovi errori per cui dovranno escogitare nuove soluzioni. Trasformazione senza evoluzione.
Foto di scena ©Wonge Bergman
• Il tempo senza interruzioni
Chi oggi plaude con entusiasmo appassionato MO, non ha mancato certo di annoiarsi. Non c’è nulla di male o ipocrita in questo, ma va detto che nell’arco di ventiquattro ore l’insofferenza (emozione di importanza capitale, spesso sottovalutata) ha spesso gonfiato sospiri, qualche imprecazione, nonché moltissimi applausi nervosi. Verrebbe infatti da chiedersi se Fabre non avrebbe potuto sfruttare meglio questa enorme quantità di tempo con più ritmo, più contenuti, più coinvolgimento diretto. Ma di nuovo MO non è uno spettacolo.
Le ore infatti passano, le azioni si ripetono fino allo stremo (spesso oltre venti minuti per un gesto reiterato come salti, piroette, lamenti per un’immane prova di resistenza per gli attori-atleti che ha del prodigioso), fuori la notte cede il passo al giorno, ma il più degli spettatori resta stoicamente in sala, non riesce a sottrarsi. Dopo le prime sei ore il corpo si abbandona e scatta un’inversione di normalità: l’anomalia non è ritornare puntualmente in sala ma scoprire che fuori il tempo sta scorrendo e non sentirsene più parte.
Ecco il mistero dionisiaco di Fabre, la creazione di un altro tempo, di un luogo altro, di una dimensione altra. Come molti altri artisti del secondo Novecento (si pensi, ad esempio, alle ultime pratiche di Marina Abramović) ci porta a riscoprire il senso del raccoglimento, della lentezza, della consapevolezza del Tempo. Poco prima della esplosione finale in un nuovo baccanale, infatti, sì dirà: Voglio una vita senza interruzioni. È il tempo tragico, un tempo che non concede spazio alla normalità , alla banalità: qui tutto è grave, significativo, estremo, eppure allo stesso tempo effimero, perché una tragedia non ne evita un’altra, la natura umana risponde prima di tutto solo a sé stessa non alla storia altrui.
Tutto insomma si ripete, si ripete, si ripete: oggi come ieri, a teatro come fuori. O come scriveva Anassimandro: Là, da dove le cose provengono, ritornano, pagando l’un all’altra il castigo di essere venuto secondo l’ordine ingiusto del tempo.
Letture consigliate:
• La tragedia secondo Jan Fabre, di Andrea Porcheddu (Gli Stati Generali)
• Tra gli dei sul Mount Olympus con Jan Fabre, di Anna Bandettini (Repubblica)
• Uno pseudo artista che non regala vitalità, di Franco Cordelli (Corriere della Sera)
• Obscene Purgation. Pure Obscenity., di Luk Van den Dries
• Jan Fabre: Mount Olympus, AA.VV. (Stratagemmi | Teatro e Critica)
• Programma di sala, a cura di Luca Del Fra
Ascolto consigliato
Teatro Argentina, Roma – 17-18 ottobre 2015
MOUNT OLYMPUS – TO GLORIFY THE CULT OF TRAGEDY
A 24h performance
Interpreti Lore Borremans, Katrien Bruyneel, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Renée Copraij, Anny Czupper, Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Piet Defrancq, Mélissa Guérin, Stella Höttler, Sven Jakir, Ivana Jozic, Marina Kaptijn, Gustav Koenigs, Sarah Lutz, Moreno Perna, Gilles Polet, Pietro Quadrino, Antony Rizzi, Matteo Sedda, Merel Severs, Kasper Vandenberghe, Lies Vandewege, Andrew Van Ostade, Marc Moon van Overmeir, Fabienne Vegt
Ideazione, Regia Jan Fabre
Coreografia Jan Fabre e i danzatori
Testi Jeroen Olyslaegers, Jan Fabre
Musiche Dag Taeldeman
Drammaturgia Miet Martens
Assistente alla regia Floria Lomme
Luci Jan Fabre, Helmut Van den Meersschaut
Costumi Jan Fabre, Kasia Mielczarek
Partecipazione alla drammaturgia Hans-Thies Lehmann,
Luk Van den Dries, Freddy Decreus
Direttore di produzione Ilka De Wilde
Direzione tecnica André Schneider
Direzione di produzione in tour Sebastiaan Peeters
Tecnici Wout Janssens, Jan Balfoort, Vic Greven
Ingegneria audio e video Tom Buys
Assistente ai costumi Maarten Van Mulken
Props Roxane Gide, Allessandra Ferreri